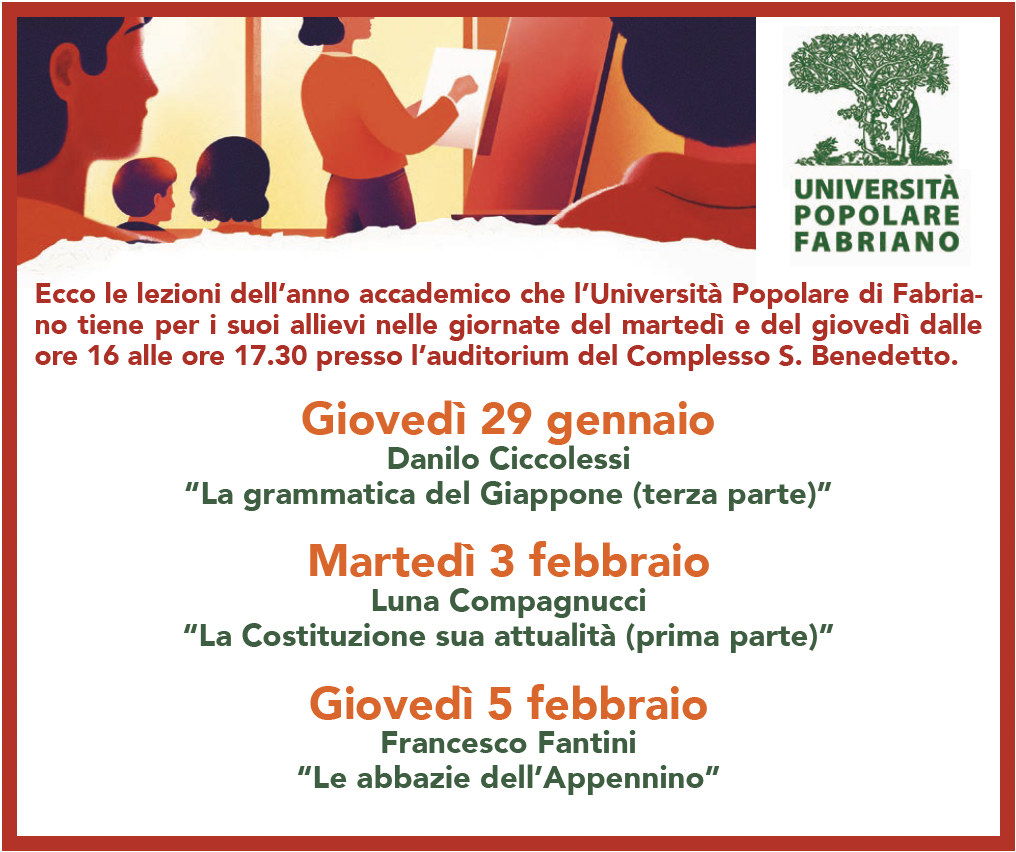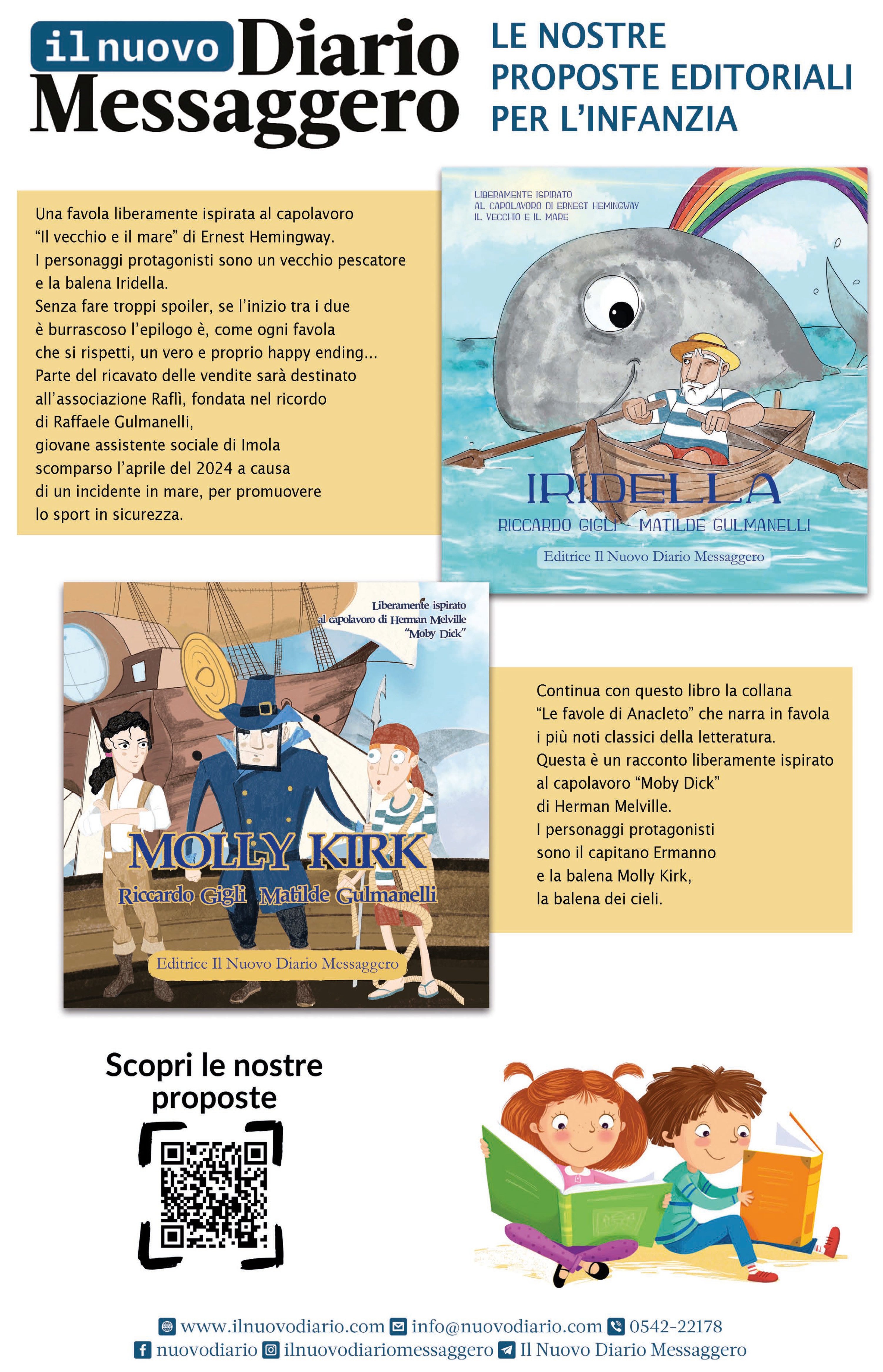Per i giovani il futuro come spazio di fiducia
Questa volta la tragedia ha coinvolto un giovane del nostro territorio, diciamo di casa. C’è dolore, sgomento. Nelle piccole città ci si conosce tutti. Le morti avvengono sempre per futili motivi, si dice, un clichè claudicante ma che fa sempre comodo. Non siamo dentro all’Iliade, Troia non brucia, ma Gaza sì. La frustrazione sarebbe cosa buona se portasse alla fondazione di un mondo nuovo. Ma il futuro slitta, per i figli e per i padri. Tutto quello che vediamo in questi giorni ci porta solo all’anestesia: bombardamenti, auto che saltano in aria, un femminicidio ogni tre giorni, accoltellamenti ed agguati. Ci stiamo abituando, non abbiamo gli anticorpi contro la violenza, perché dovremmo pretenderli dai giovani. Diventa normale portarsi il coltello in tasca in discoteca. Poi l’occasione ci sarà sempre: la droga non pagata, la fidanzata guardata in un certo modo, un pestone casuale. Una riflessione dedicata al rapporto dei giovani con il tempo potrebbe avere per titolo semplicemente “I giovani e il futuro”; questa è infatti l’unica dimensione temporale che essi percepiscono: il tempo che hanno davanti a sé. D’altra parte, quello che hanno alle loro spalle è troppo breve per poter costituire una memoria significativa. E il presente? In esso sono immersi, e lo vivono – forse al pari di molti adulti – come una realtà così scontata da non rendersi conto di essa. Se ne rendono conto quando è troppo disordinato, arruffato; in quelle situazioni allora appare che la libertà di occupare il tempo secondo il desiderio del momento o i propri capricci non è per niente appagante. Anche l’istante nel quale sono immersi ha bisogno di ordine, di ritmo, per diventare veramente esperienza di serenità e di crescita. La necessità di una disciplina per la propria vita è difficile da proporre alle nuove generazioni, al di fuori di un contesto che mostri di essa l’utilità e il valore come stile di vita che può restituire tranquillità e armonia alle proprie giornate. Il tempo verso cui la tensione dei giovani è protesa è il futuro; questa è la dimensione attesa, desiderata. Il futuro è la vita in cui ha inizio l’autonomia, la realizzazione dei propri progetti, dei propri desideri. Non ci sono ancora delusioni e quindi ci si può orientare verso il domani caricandolo di aspettative e di idealità. Anche i ragazzi e le ragazze di oggi guardano al futuro con il desiderio di realizzazione personale e aspirano a una vita piena, serena, in cui poter concretizzare i propri sogni: trovare un lavoro soddisfacente, costruire relazioni autentiche e durature, e “diventare qualcuno” senza perdere la propria autenticità. Accanto a questo slancio positivo vi è nei giovani uno sguardo preoccupato. Il tema del futuro è più facilmente comprensibile alla luce delle considerazioni svolte qualche settimana fa in queste pagine sul tema dei giovani. In una ricerca realizzata dall’Osservatorio dell’Istituto Toniolo qualche anno fa risultava un dato inquietante: il 67% dei giovani interpellati nell’ambito dell’indagine dichiarava di pensare il proprio futuro come pieno di rischi e di minacce. Si tratta di una percentuale che si è mantenuta stabile nel corso degli anni, con un peggioramento nel periodo della pandemia, quando la fiducia nel futuro si è abbassata significativamente, mostrando nella popolazione femminile la componente più fragile e più sensibile alle ragioni della paura. La pandemia, le crisi economiche, le guerre e il cambiamento climatico incidono profondamente sulle nuove generazioni. «Ho ansia e paura per il futuro – dice un giovane diciottenne –, il mondo è a rotoli». La sottile sfiducia verso gli adulti e soprattutto verso le istituzioni accentua il senso di precarietà e l’incertezza della realizzazione dei propri progetti e obiettivi. Le cause sociali e strutturali si riflettono sul piano individuale e danno forma a un interrogativo sulla propria persona, sulla propria identità. Dice un giovane ventiduenne: «Che futuro avrò? Che persona sarò? Chi sarò tra 5-10 anni, domani? Troverò una svolta nella mia vita?». Al tempo stesso vi è nelle ragazze e nei ragazzi di oggi la consapevolezza del delicato valore della loro età e della loro condizione. Dice una giovane: «Attraverso l’adolescenza so che da una bozza di ciò che sono ora può uscire un capolavoro». È come sentirsi un prezioso vaso di cristallo che prende forma a poco a poco nelle mani di un artigiano che, per quanto esperto, corre sempre il rischio di spezzarlo. Ragioni esterne e interiori si intrecciano; per qualcuno troppo fragile questa situazione diventa una sfida insostenibile; per molti, motivo per approfondire le proprie ragioni, il proprio atteggiamento di fronte alla vita, per rendere più mature le proprie scelte. Dietro la paura del futuro c’è spesso una domanda spirituale implicita: «Perché vale la pena vivere, impegnarsi, sperare?». Anche nell’inquietudine rispetto al futuro molti giovani esprimono la loro domanda di senso, la loro inquietudine spirituale, che spesso non approda alle forme religiose tradizionali ma che rivela tratti di una nuova ricerca: di relazioni autentiche, di cura del sé, di connessione con la natura, di armonia interiore, di giustizia sociale. Pensare a un futuro pieno di rischi e di incognite non significa restare di fronte a esso passivi e rassegnati, ma piuttosto consapevoli. I giovani oggi sanno che il futuro non verrà loro incontro in maniera scontata, ma richiederà loro impegno, intelligenza, determinazione. La complessità del futuro spaventa meno quei giovani che possono far conto su una famiglia accogliente, presente, capace di dialogo; questi si sentono meno soli davanti all’ignoto e alla loro paura di fallimento. In contesti familiari fragili, soprattutto dal punto di vista relazionale, l’incertezza del futuro rischia di essere vissuta come minaccia concreta, più che come sfida potenziale. Accanto alla famiglia, il sostegno per guardare al futuro con fiducia sono gli amici. Il futuro smette di essere un nemico quando lo si affronta “insieme”. I rapporti amicali possono aiutare perché costituiscono la grande risorsa del mondo giovanile. L’amicizia è una delle forme principali di spiritualità vissuta: è un luogo di fiducia, di presenza, di dono reciproco. Molti giovani che si dichiarano “non religiosi” trovano proprio nell’amicizia quell’esperienza del bene gratuito che un tempo veniva mediata da contesti religiosi o comunitari. L’amicizia diventa così un luogo del bene gratuito, una via relazionale alla fiducia, in cui il futuro non appare più come una minaccia ma come un cammino condiviso. Anche attraverso l’amicizia l’inquietudine verso il domani rappresenta la porta che apre a un’esperienza spirituale. «La serenità in famiglia e il sostegno dei miei amici – dice un ragazzo – costituiscono l’aiuto più concreto per affrontare il futuro». L’orizzonte di senso dei giovani non è individualista ma relazionale. L’incertezza del futuro non è eliminabile, ma è abitabile se è possibile viverla nel sostegno reciproco. In questa prospettiva, ciò che potrebbe aiutare i giovani ad affrontare il futuro in modo più positivo non è tanto una – improbabile – promessa di stabilità, quanto la possibilità di radicarsi in legami significativi e in una visione di sé che dia direzione e valore all’imprevedibile e ne trasformi il potenziale distruttivo in una risorsa per crescere. Si assiste però purtroppo anche ad un oggettivo calo del gusto, vivendo in una stagione esteticamente orrenda. Non puoi chiedere gentilezza e bellezza a chi si sta trasformando in… zombie. Un plauso invece va ad una grande azienda quotata in borsa per la pubblicità che sta girando in questi giorni. Due leggende del cinema che insieme fanno 170 anni Robert De Niro e Al Pacino, si incontrano in un luogo attorno ad un tavolino con quattro sedie vuote. Si domandano come va, si abbracciano come i vecchi in osteria. E poi uno dice: “E’ freddo fuori”. E l’altro: “Ma dentro è caldo”. La grande spa vende piumini alle nuove generazioni e dice a tutti che è tempo di invertire la rotta con le parole giuste. Servono anche quelle in un terreno minato dove spesso si sbaglia anche il respiro.
Carlo Cammoranesi