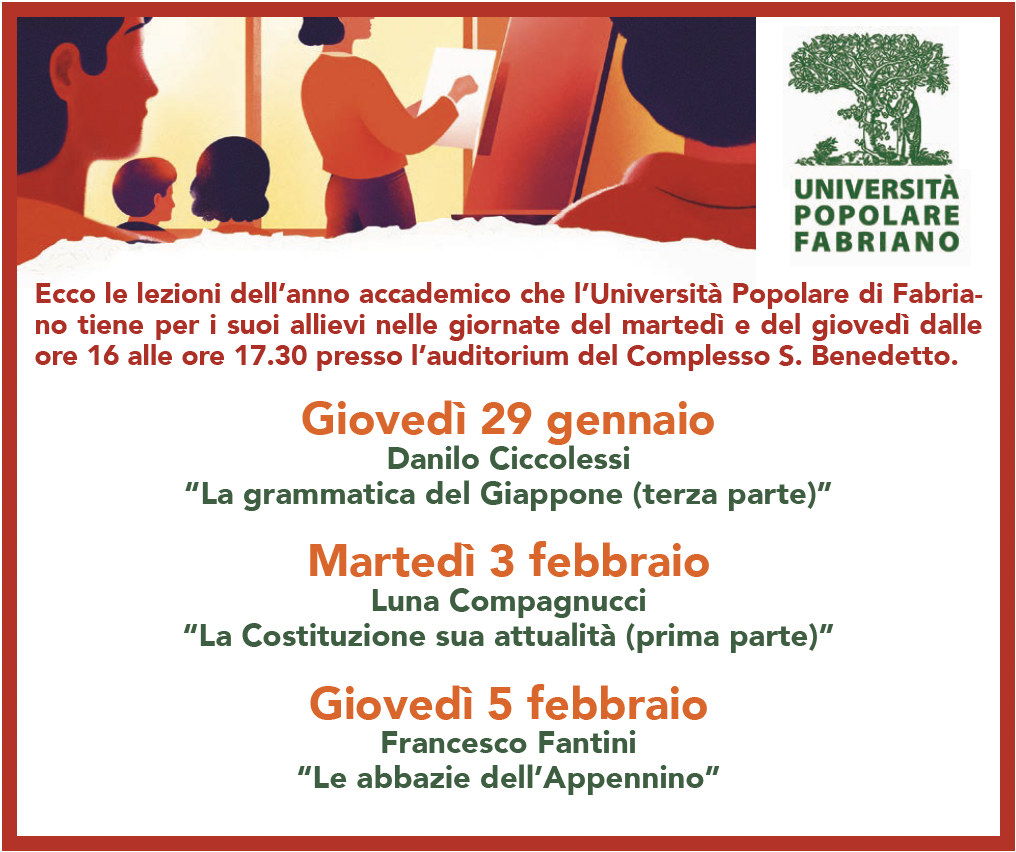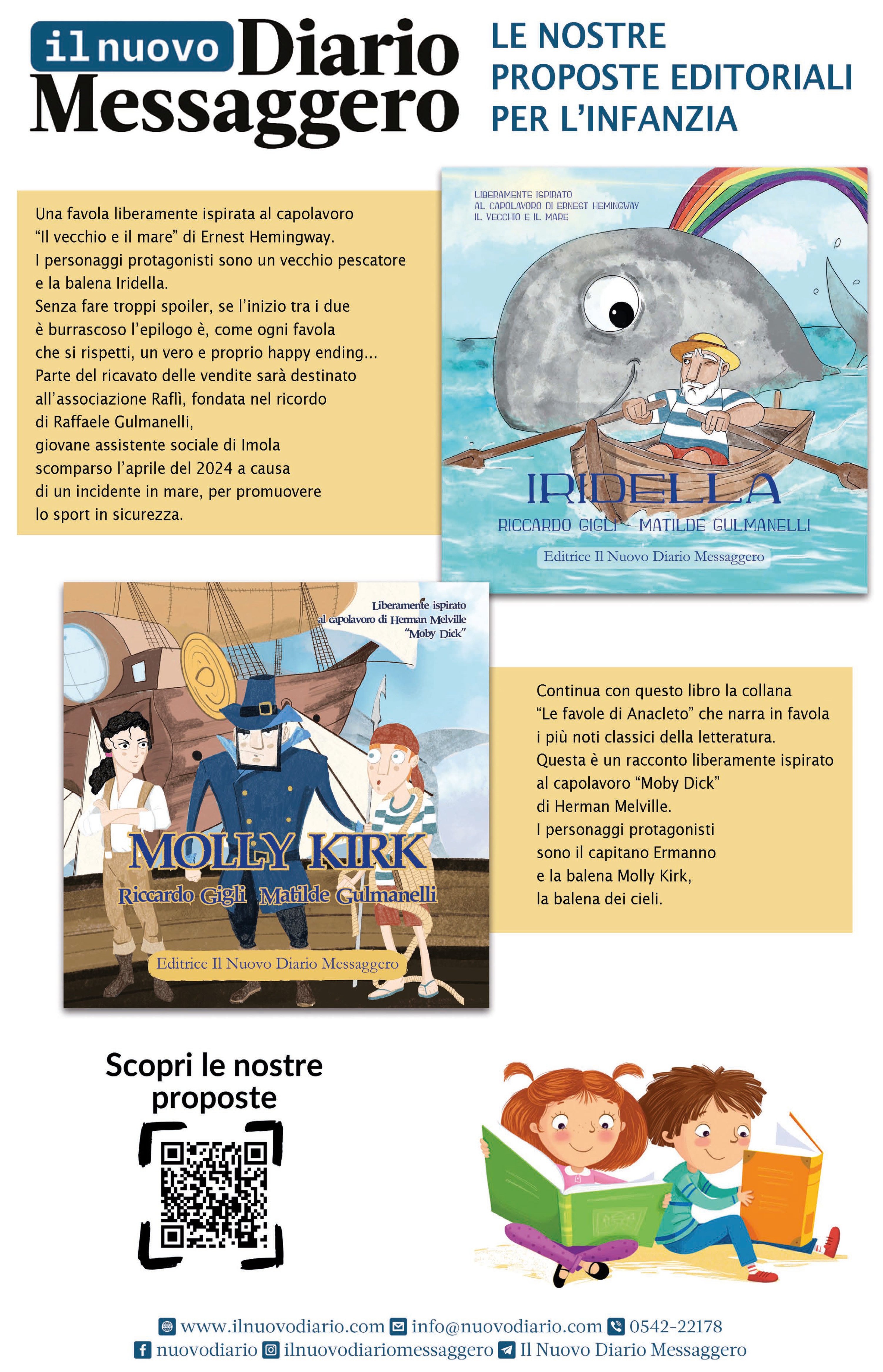Serve un luogo educativo
Spesso la scuola è al centro dei nostri pensieri e preoccupazioni, quasi come un mantra educativo. Viviamo in un mondo in cui tutto sembra stia crollando. Di fronte a ogni emergenza si corre ai ripari cercando di chiudere i buchi, di riparare l’ultima falla, il più delle volte senza criteri ideali di riferimento, senza porsi il problema se esista un bene possibile da costruire o un male incombente da evitare. Siamo sempre alla ricerca di norme o iniziative che affrontino le emergenze, ma che il più delle volte si rivelano inefficaci esigendo di essere sostituite da altre norme, da altre iniziative. Così accade nell’organizzazione della sanità, così di fronte al dramma dei migranti, così sul tema sicurezza, così anche per quanto riguarda la scuola. Quando poi l’emergenza diventa un vero e proprio tsunami, come quello attuale dei dazi e dei mercati, diventa ancora più difficile intravvedere nelle reazioni dei singoli governi scelte riconducibili a criteri di valore. Ma in fondo è come se anche noi fossimo diventati incapaci di affermare ciò che è bene e ciò che è male, incapaci di riconoscere ciò che corrisponde al desiderio del cuore. Rischiamo di non avere neppure più il coraggio di alzare la testa per affermare che la libertà della persona, la pace, gli equilibri democratici, sono un bene irrinunciabile e che le norme condivise del diritto internazionale o addirittura le decisioni di una Corte internazionale non possono soggiacere all’arbitrio di un singolo capo di stato. Eppure quando vediamo che in mezzo alle macerie di Gaza c’è ancora chi ha il coraggio di scendere in strada e di gridare “Vogliamo vivere”, o quando ci sale la commozione per quei popoli che sfidando la crudeltà della repressioni osano opporsi a governi violenti e liberticidi, allora anche il nostro desiderio può riaccendersi e parole come pace e libertà cessano di essere parole vuote e desuete e tornano ad accamparsi davanti a noi come qualcosa per cui potrebbe anche valere la pena alzare la testa. Quando l’esperienza del bene si riaffaccia all’orizzonte, torniamo ad accorgerci che in fondo siamo capaci di desiderare un mondo più giusto e tutto sommato potremmo anche impegnarci perché le cose andassero meglio. E soprattutto a quel punto potrebbe anche tornarci l’energia per stare davanti allo “smarrimento” di questi nostri giovani. Sì, perché le vittime più fragili del drammatico disorientamento nel quale viviamo sono proprio loro. I nostri figli, i giovani. I giovani che si tolgono la vita, quelli che uccidono, quelli che riempiono la noia con la violenza, quelli che abbandonano la scuola, quelli che sembrano non cercare altro che restare da soli davanti a uno schermo, quelli che non hanno paura a dirti che la vita fa schifo. La generazione di questi ragazzi, che oggi si stanno affacciando all’università o al lavoro, è la generazione che è entrata nella scuola media superiore ai tempi del Covid, che per due o tre anni non ha avuto neppure l’esperienza viva della scuola. Il gusto di incontrare i compagni, di condividere esperienze, l’amicizia, magari anche la passione per qualche materia che dal vivo di un rapporto si poteva scoprire. Tutto questo, e tanto altro, la scuola on line non lo ha consentito. Anche il Covid ha contribuito a farci capire che della scuola abbiamo bisogno, non possiamo proprio rinunciarci. Oggi è una scuola che fa acqua da molte parti, che ha bisogno di essere riformata, riparata, cambiata. Ma tutti i limiti che potremmo elencare non possono cancellare il valore di un luogo che qualunque civiltà ha sempre concepito come luogo dedicato alla cura della mente e dell’animo, fatto per incrementare l’umano, dove trasmettere il sapere. Un luogo di convivenza, dove non si è da soli, dove circolano conoscenze e competenze, dove si sta a mollo nella storia, dove si impara come è fatto l’universo. Di tutti questi fattori hanno bisogno i giovani per crescere, ma anche gli adulti ne hanno bisogno. Proprio in un tempo di crisi e di vuoto come il nostro la scuola può tornare ad essere un interlocutore attivo all’interno del contesto sociale. Un soggetto che dialoga con il mondo del lavoro e delle professioni, che interagisce con la società, un luogo capace di ospitare cultura e ricerca, un ambito abilitato a proporre arte, scienza, bellezza, poesia. Un’occasione in cui anche i genitori possano portare la ricchezza della loro esperienza umana e professionale liberandosi del triste ruolo di sindacalisti arrabbiati dei propri figli. Riforme, nuove linee programmatiche, revisione dei programmi e della valutazione, rinnovamento dei sistemi di reclutamento dei docenti, sono un refrain che da sempre, e oggi ancora di più, accompagna la vita della nostra scuola. E ben venga ogni tentativo che tenda a migliorare! Soprattutto ogni cambiamento che vada nella direzione di un incremento della libertà di educazione dei docenti e delle istituzioni. Perché la scuola, nel trasmettere conoscenze e competenze, nell’avviare al lavoro o nell’introdurre all’Università, inevitabilmente diventa luogo educativo. E non può esistere educazione disgiunta dalla libertà. Libertà degli insegnanti. Libertà degli studenti. Libertà delle istituzioni. È la libertà sancita dalla Costituzione. Ma è soprattutto quell’amore alla libertà che guarda ogni studente con la consapevolezza di essere di fronte a qualcuno misteriosamente grande, bisognoso di essere abbracciato, sfidato, risvegliato. Un pozzo di disagio, ma anche di domanda, di bisogno, di desiderio. Una libertà forse da riaccendere, perché sia sempre più capace di desiderare e di giudicare. Ciò che Einstein ebbe a dire a degli studenti potrebbe oggi essere detto a ogni insegnante: “La preoccupazione dell’uomo e del suo destino devono sempre costituire l’interesse principale di tutti gli sforzi tecnici. Non dimenticare mai questo nel mezzo dei tuoi diagrammi ed equazioni”.
Carlo Cammoranesi