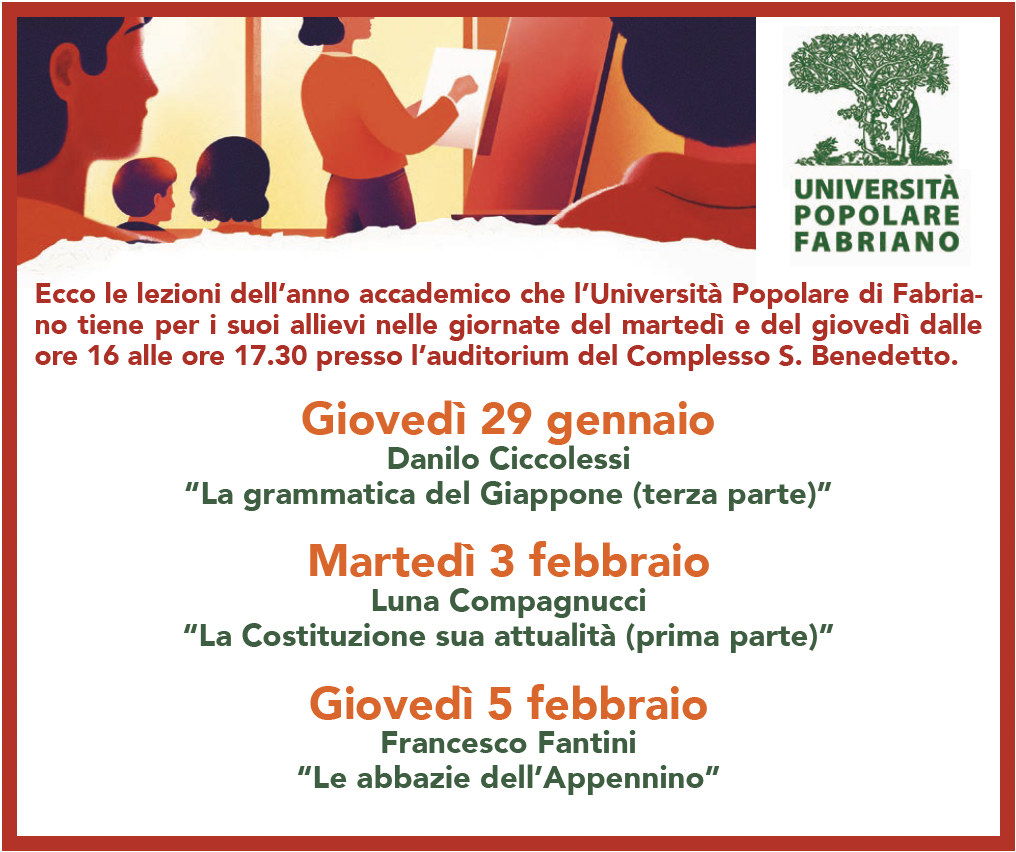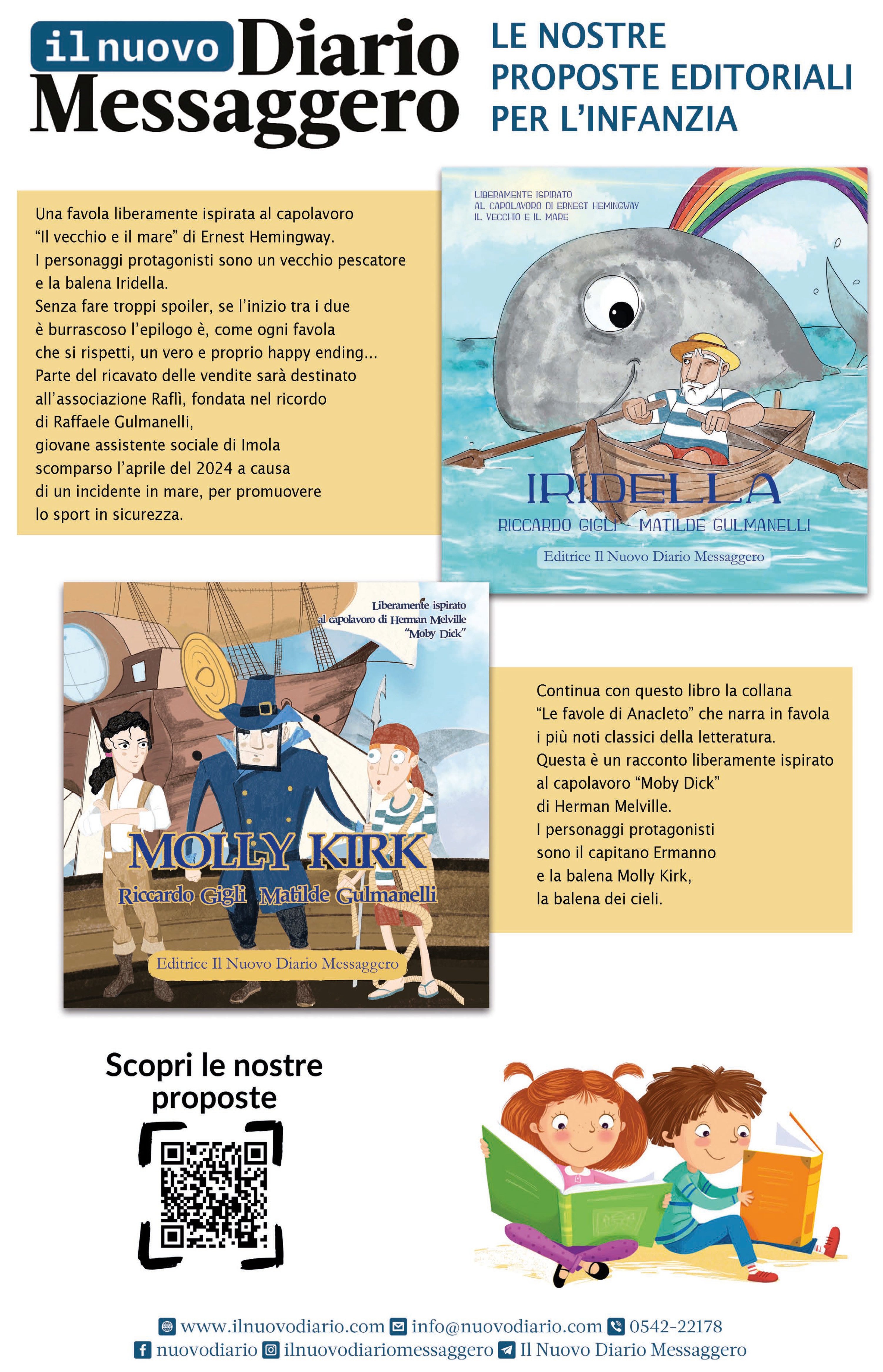La via indicata da Papa Francesco
La vita, nella sua arcana bellezza, ha un percorso che non stabiliamo noi, pur vivendola. Ha un insieme di mistero ed imprevedibilità che la rende ancor più attrattiva ed interessante agli occhi del mondo. Niente di scontato, di stabilito, educativa al massimo. Starci con tutto noi stessi senza pretendere di imporne un inizio e una fine. Pensavamo a questo mentre ascoltavamo sgomenti la notizia della morte di Papa Francesco. Giunta in un giorno di festa, Lunedì dell’Angelo. Giornalisticamente per noi un giorno in meno per confezionare il giornale, quindi un cammino già anticipato per forza di cose. E allora? La vita irrompe con il suo disegno senza preavviso o segnalandoci l’imprevisto. Si cambia “palinsesto”, si accantonano grafica e contenuti di pagine realizzate, che non saranno mai lavoro perso. E’ l’occasione per imparare da un presente che spesso non sappiamo accettare. Ci ha lasciato un Papa. Morire nel lunedì dell’Angelo. L’Angelo oggi è la storia, ma è anche l’umano, un umano che in questo tempo possiamo accostare con strumenti che fino a pochi anni fa erano impensabili e di cui non si può avere paura. Non si può temere la propria fragilità, il proprio male, il proprio peccato, e non si può riempire il cammino dei singoli di maldicenze che paralizzano il cammino di tutti, cercando di dare vesti candide alla propria invidia e alla propria ambizione: far diventare motivo di scandalo un’umanità ferita significa rinnegare – di fatto – l’evento stesso della salvezza. La storia e l’uomo sono oggi quell’Angelo che introduce nel tempo la notizia nuova della Resurrezione, che reintroduce nel nostro sguardo dominato da ogni tipo di moralismo, la freschezza di qualcosa che c’è e che si muove. Qualcuno che c’è e che si muove. Eppure quell’Angelo è ancora di più: è l’Angelo di Dio. Viviamo tempi in cui di tutto siamo curiosi tranne che di Dio. La storia, l’uomo e Dio dovrebbero essere il tormento della Chiesa, ciò che la tiene sveglia e non la fa assopire al tepore di rassicuranti discordie e diatribe. I resoconti medioevali ci dicono che commozione e stupore assalivano gli astanti quando sul palcoscenico della rappresentazione compariva l’Angelo: essi intuivano che si apriva per loro l’occasione di una conoscenza nuova, di una comprensione più vera del dolore, dell’amore, dell’amicizia. A pensarci bene tutti vorremmo un’esperienza così, tutti vorremmo poter sussultare di gratitudine davanti al nostro tempo apparentemente ingrato, davanti al nostro umano apparentemente disumano, davanti ad un Dio improvvisamente vicino. A pensarci bene tutti vorremmo di nuovo poter essere curiosi. Tutti vorremmo che ogni giorno non fosse soltanto un lunedì. Ma un lunedì dell’Angelo. Come quello che ci ha portato via per restituircelo alla gloria di Dio il nostro Papa Francesco. Davanti alla crisi, davanti ai drammi mondiali, Francesco ha reagito come un cristiano nel quale il cristianesimo non si è trasformato in una “dottrina senza mistero” o in una “volontà senza umiltà”. Ha risposto alzando lo sguardo, “riconoscendo la presenza di Gesù Cristo e seguendo”. Questo cristianesimo cristiano di Francesco, questo restare “affascinato e pieno di stupore di fronte alla eccezionalità dell’incontro con un avvenimento, con una Persona” è ciò che ha reso luminoso il suo pontificato. Luce per un mondo in transizione, ferito dal collasso dei tempi moderni. Chiarezza per una Chiesa attraversata da una crisi severa dove la fede dei semplici tende ad essere confusa da richieste clericali che mettono in discussione il suo fondamento e la sua garanzia: l’autorità. Francesco ha guardato all’essenziale e annunciato, instancabilmente, la grande gioia dell’Incarnazione. Francesco non metteva in primo luogo la Chiesa in crisi: la sua insistenza era sul cristianesimo come avvenimento di grazia e le resistenze che provocava nel nome della corretta dottrina svelano fino a che punto la grande crisi dopo il Vaticano II sia questa e non quella degli anni ‘70. La crisi di chi si scandalizza perché la Chiesa respinge l’egemonia, di chi ha confuso le conseguenze etiche e dottrinali con l’origine della fede, di chi insegna la morale al successore di Pietro. Davanti a un Papa che ha evidenziato la cristianità del cristianesimo emerge “l’ossessione per la legge, l’attrazione a mostrare conquiste sociali e politiche, l’ostentazione della cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, la vanagloria connessa alla gestione di questioni pratiche, il fascino delle dinamiche di autostima e di realizzazione autoreferenziale”. Sono tutti sintomi. Sono il sintomo della resistenza a quello che di più cristiano c’è nel cristianesimo: un Altro che ci accade. Al momento della sua elezione Francesco aveva ereditato una Chiesa a pezzi, macchiata dallo scandalo della pedofilia del clero, da quelli finanziari, da Vatileaks. Il Papa ha saputo, con la sua testimonianza personale, restituire alla Chiesa la sua dignità, il suo rilievo nella scena internazionale. Ha saputo altresì muovere le acque stagnanti di un cattolicesimo ingessato, reattivo, impaurito di fronte alla secolarizzazione. Un cattolicesimo tutto centrato sulle questioni etiche, dimentico di evangelizzazione e di promozione umana, la coppia polare che sta al centro di Evangelii nuntiandi di Paolo VI, documento basilare per il Bergoglio pensiero. A questo cattolicesimo clericale, essenzialmente “conservatore”, Francesco ha indicato la via della Misericordia come strada attraverso cui Cristo può toccare il cuore dell’uomo contemporaneo. È la stessa via indicata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. È la Chiesa come “ospedale da campo” per i feriti della storia, delle guerre spirituali e materiali del nostro tempo, per i borderline, gli abitanti delle periferie geografiche ed esistenziali, per i poveri del mondo. Quelli che ha sempre visto al primo posto. Una rivoluzione umana che ora necessita di essere proseguita. Senza abbandonarsi ad uno stupido gioco da toto-conclave. E’ lo Spirito a decidere. Non altri.
Carlo Cammoranesi