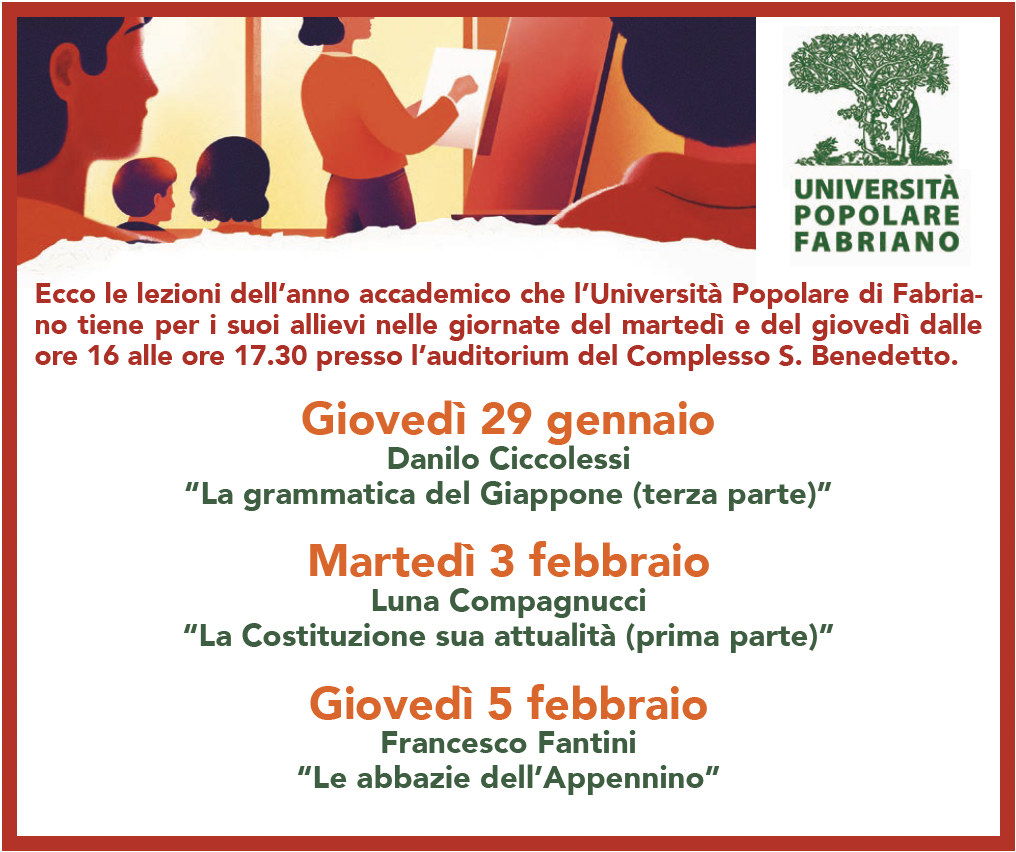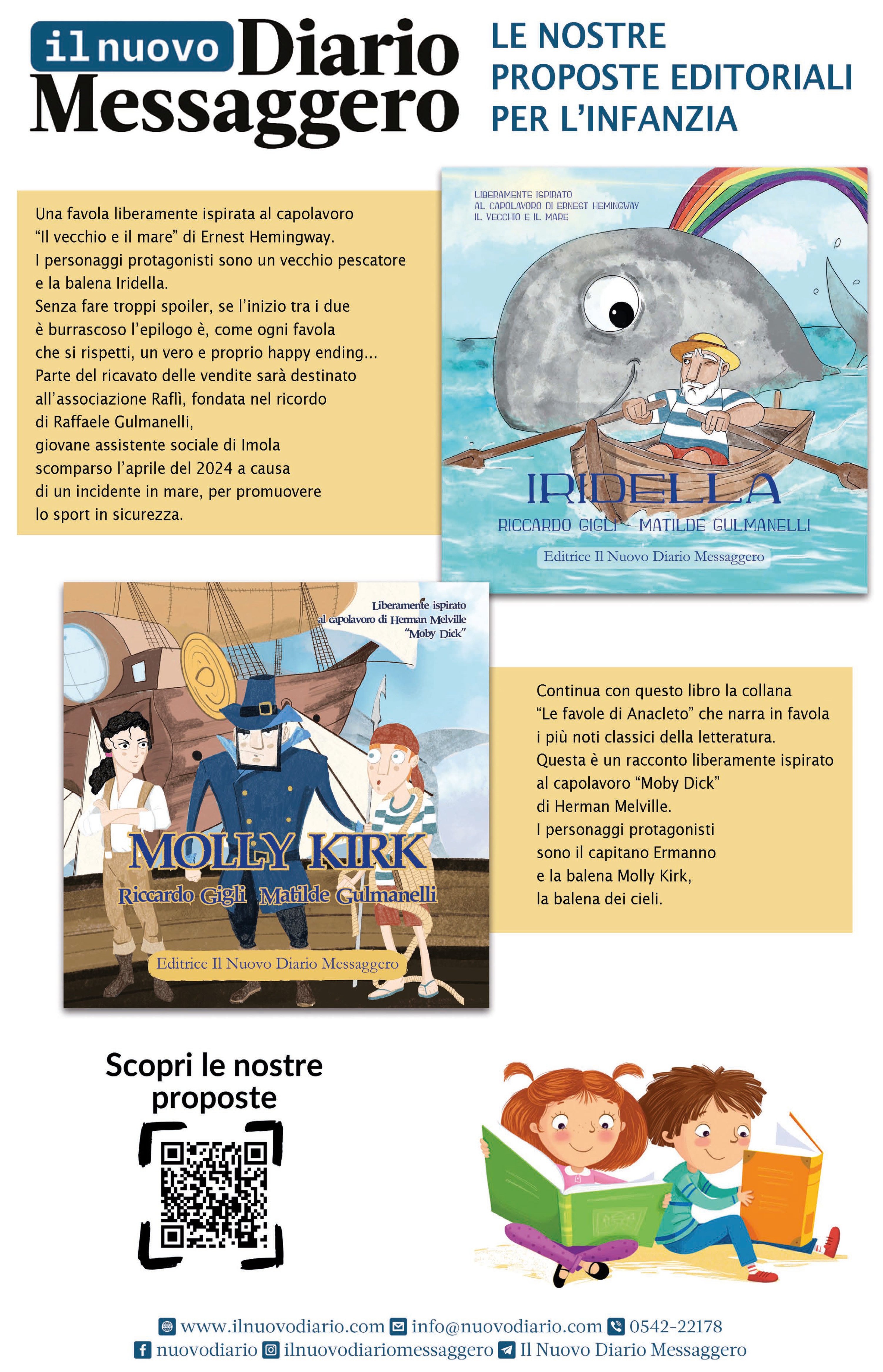Il diverso non è un nemico
Nella sua prima intervista da Papa, Leone XIV ha rivolto un appello per la pace: “Mettiamoci insieme a cercare soluzioni per la guerra”. In un tempo segnato da conflitti multipli e parole gridate, colpisce il tono sobrio e pacato con cui Papa Leone XIV ha scelto di presentarsi al mondo. La sua prima intervista non ha avuto nulla di eclatante. Eppure, proprio nella semplicità del suo linguaggio si avverte qualcosa di profondo. Quando dice “mettiamoci insieme a cercare soluzioni per la guerra”, non chiede di schierarsi, non invita a prendere posizione. Propone piuttosto di stare, tutti, dentro alla realtà. Di assumerla. Di condividerne il peso. Il suo stile, fin dai primi passi, appare distinto: non teorico, non programmatico. Piuttosto legato all’esperienza. Alla concretezza di chi ha abitato la Chiesa tra la gente, nelle periferie del mondo. Nella sua conversazione televisiva ha nominato l’angoscia di chi vive oggi sotto le bombe. Ha parlato delle guerre come di qualcosa che lo riguarda personalmente: “penso giorno e notte a quanti innocenti stanno morendo”. È una frase semplice, ma non generica. Dietro, si intuisce una coscienza vigile, attenta al dolore e poco incline alla distrazione. Non c’è bisogno di un elenco di tragedie per intuire che Leone XIV conosce la geografia della sofferenza umana. E non si accontenta di guardarla da lontano. La visita è stata l’occasione per ricordare che ogni voce, oggi, corre sul filo di parole e immagini che costruiscono o distruggono. Il Papa ha parlato della comunicazione come di un dono e di una responsabilità: non per veicolare idee astratte, ma per favorire legami, per avvicinare ciò che appare lontano, per ridare all’umano una possibilità di riconoscersi. In questo senso, la proposta di “mettersi insieme” non è uno slogan. È un atteggiamento. Non si tratta solo di trattative o mediazioni politiche: si tratta di riscoprire il volto dell’altro, di non ridurre nessuno a funzione, nemico o simbolo. È un invito che ci riguarda tutti, non solo chi guida le nazioni. In ogni casa, in ogni gruppo umano, in ogni relazione può accadere qualcosa che assomiglia alla guerra: la rottura, l’incomprensione, l’odio. E allora cercare soluzioni non è solo un compito per i grandi: è il lavoro quotidiano del vivere. Il Papa non ha parlato da stratega, né da analista. Ha parlato da credente. E ha rivolto il suo sguardo al mondo come lo si guarda quando ci si sente responsabili. Non per dovere, ma per vocazione. E’ un altro modo di esserci, forse più sottile ma altrettanto decisivo: restare fedeli al dolore, stare in ascolto, tenere insieme le cose. È quello che Leone XIV sembra voler fare: non guidare da fuori, ma camminare con. Far parte di un popolo, non semplicemente indicarne la rotta. Nel mondo di oggi non è poco. Forse è proprio quello che manca. E che più desideriamo. Non stiamo andando verso un mondo più capace di inclusione, comprensione e coesistenza. Al contrario, si assiste a un lento arretramento del riconoscimento dell’altro. L’alterità, lungi dall’essere accolta, viene sempre più percepita come una minaccia. ?I segnali sono così numerosi e diffusi che non è più possibile ignorarli. La partner che delude le aspettative si trasforma nell’ostacolo alla nostra autorealizzazione. Fino al punto in alcuni casi di essere uccisa. Lo straniero che cerca rifugio è trattato come un invasore.?Il diverso è percepito come un errore da correggere. Il Paese limitrofo diventa terreno di conquista. Al di là della scala, la dinamica è sempre la stessa: prima l’altro è allontanato, poi opacizzato, infine privato del volto e della parola. Ridotto a oggetto da classificare, a pericolo da sradicare. E, infine, a nemico da combattere. In una società sempre più frammentata, ad aumentare è l’intolleranza.?Nella sfera pubblica, le posizioni si polarizzano, il linguaggio si fa bellico, le categorie si irrigidiscono. Le differenze non sono più occasione di confronto ma trincee da difendere. E a peggiorare le cose ci sono anche le piattaforme digitali che favoriscono nuove forme di tribalismo e chiusura. Viviamo in un paradigma culturale che ci induce a difendere a ogni costo la nostra-mia zolla di benessere, potere o identità. Ogni cambiamento, ogni segnale di trasformazione, ogni imprevisto viene percepito come una minaccia. Al punto che si vanno perdendo persino le competenze necessarie per gestire la relazione complessa con l’altro concreto. Stiamo scivolando lungo un piano inclinato, con un esito incerto. ?Tuttavia, non è troppo tardi per invertire la rotta, a condizione di prendere coscienza della situazione prima che peggiori ulteriormente, prima che la diffidenza e l’autoassoluzione rendano irreversibile il nostro isolamento. Uscire da questa deriva richiede di riconoscere che l’altro non rappresenta un ostacolo al nostro benessere, ma una condizione imprescindibile della nostra umanità. Indubbiamente, la relazione con l’altro comporta sempre un rischio. La relazione è intrinsecamente esposta alla possibilità di ferita. Pensare di poter sterilizzare questo rischio, significa impoverire la nostra stessa vita. Che, ripiegandosi su di sé, finisce per appassire. ?È pertanto necessario impegnarsi attivamente per promuovere una nuova cultura della coesistenza. Non si tratta di una semplice tolleranza, che preserva lo status quo mantenendo le distanze, bensì di un’ospitalità reciproca, capace di generare legami, progetti condivisi e nuove narrazioni. È fondamentale riconoscere che il mondo non ci appartiene, ma ci è stato affidato in comune, che la nostra identità è intrinsecamente relazionale e che la libertà non consiste nel fare ciò che si vuole, ma nel saper condividere spazi, tempi, risorse e aspirazioni con gli altri. In definitiva, si tratta di scegliere che tipo di mondo vogliamo abitare: se rimanere intrappolati nella logica della zolla, ciascuno arroccato nel proprio recinto, facendo piazza pulita di tutto ciò che è fuori dai suoi schemi o se siamo disposti a costruire una nuova ecologia relazionale. Solo riconoscendo il volto dell’altro possiamo ritrovare anche il nostro.
Carlo Cammoranesi