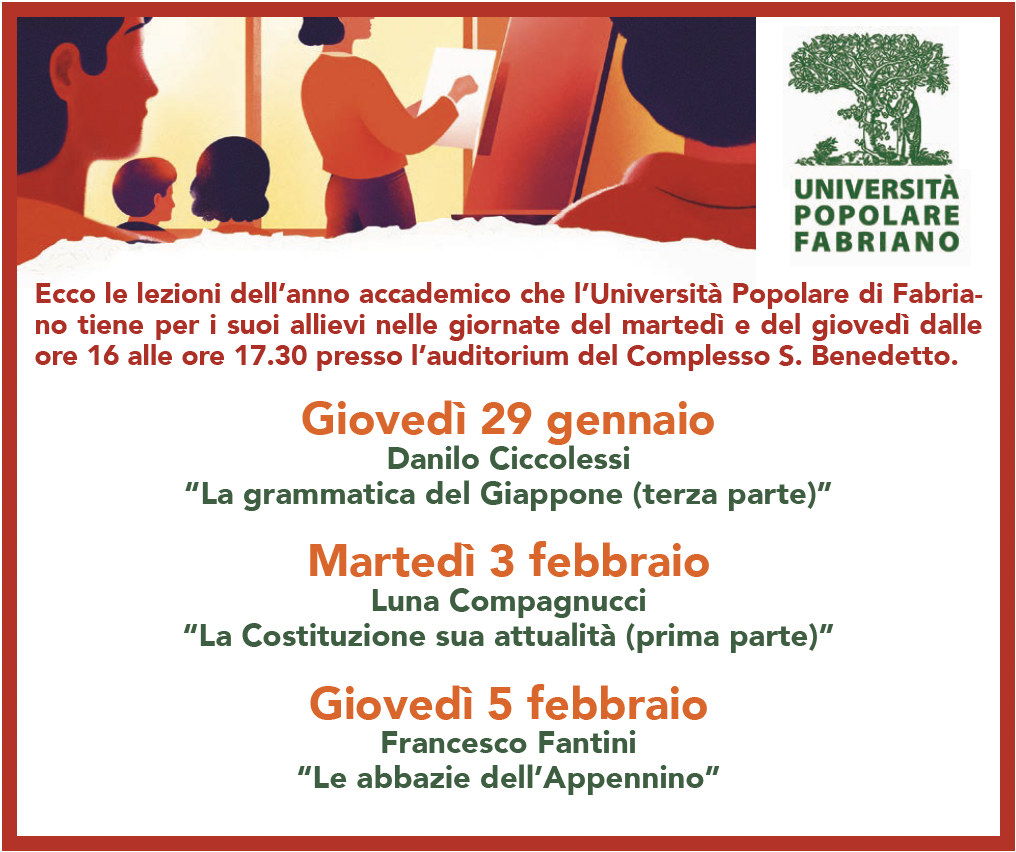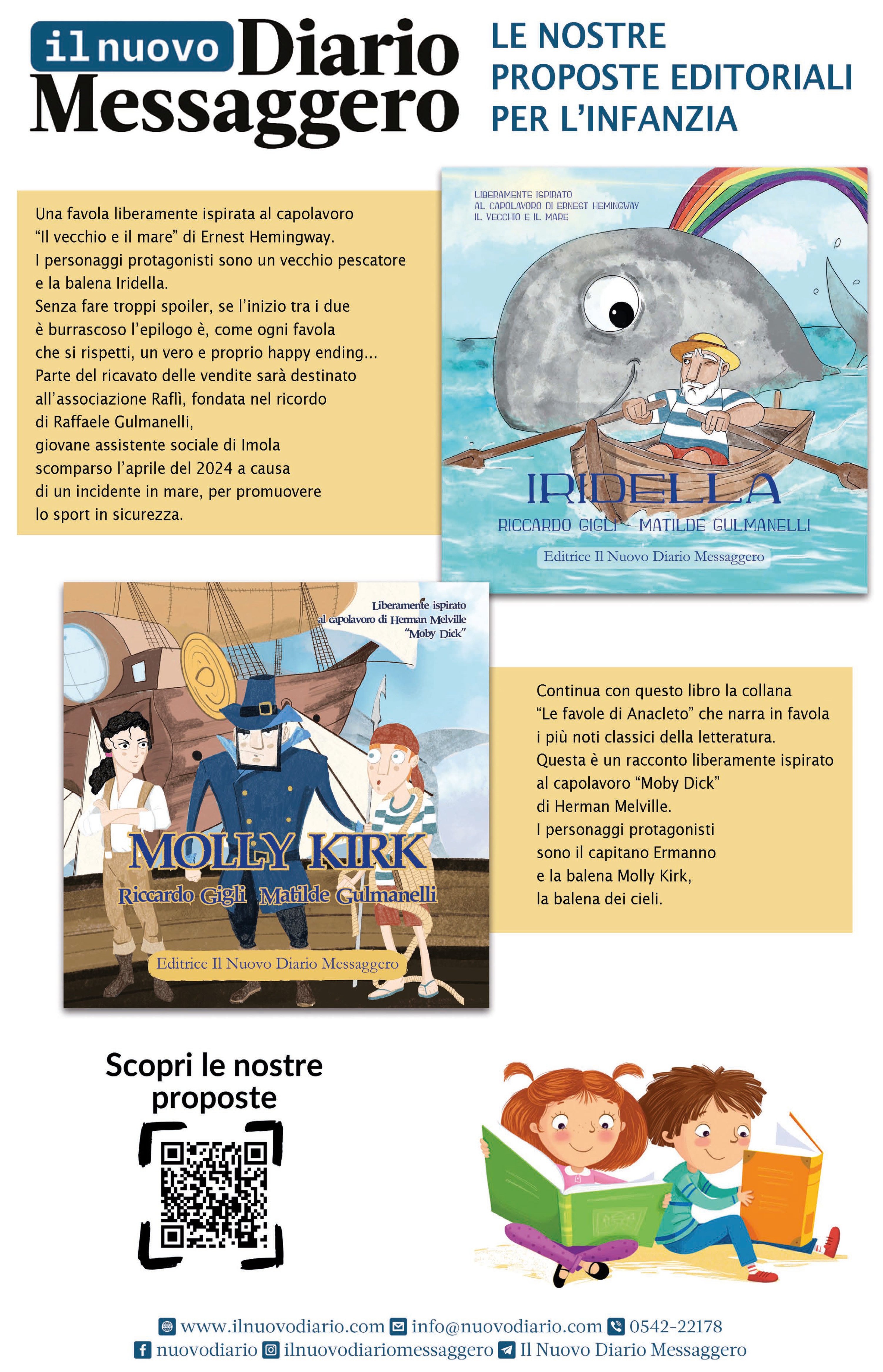Dove va l'Europa?
L’Europa? Almeno fosse un vaso di coccio tra i vasi di ferro. Le incrinature ormai evidenti sulla superficie lo rendono ancora più fragile e i tentativi in corso per ripararle, o almeno per non aggravare la profondità delle crepe, procedono a stento. ?L’Europa è un sentimento, l’ipotesi, sempre più remota, di una casa comune con una sola bandiera simbolica sul tetto e con le fondamenta cementate dagli stessi valori. Il problema è che, al di là della sfera ideale e della convenienza pratica, quell’Unione politica e economica tra 27 Stati sta andando in pezzi. E sta scegliendo di farlo nel momento peggiore: disunirsi fino al rischio estremo, ma ormai nemmeno così improbabile, di dissolversi. Nelle ultime settimane le iniziative del presidente statunitense Trump sono entrate con irruenza nell’agenda della guerra in Ucraina. Non si può negare lo sconcerto provocato dall’umiliazione pubblica subita dal presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca. In Europa, spiazzata dalle iniziative del presidente americano, si è reagito accentuando la solidarietà all’Ucraina e al suo presidente: dalle prese di posizione dei vertici della Ue alla convocazione ad opera di Macron e Starmer del gruppo dei “volenterosi”. Se da una parte si è invocata la “pace attraverso la forza” (Ursula von der Leyen), dall’altra la sensazione che i Paesi europei siano fuori gioco sembra essere una certezza. L’attuale situazione di un negoziato fuori dagli schemi e per molti versi fuori dai canoni della diplomazia, è anche il risultato di tre anni di pervicace rinuncia europea all’iniziativa diplomatica e alla via negoziale. Occorreva iniziare ben prima a dialogare. Pur sostenendo doverosamente la difesa dell’Ucraina, bisognava rischiare, senza arrendersi al primo insuccesso, nell’iniziativa politico-diplomatica alla ricerca di una soluzione negoziale. La ripresa di un dialogo tra gli Stati Uniti e la Russia è, pur con tutte le ambiguità del caso, una novità positiva, che innanzitutto ha allontanato la minaccia di una escalation fuori controllo, con pericolo di scontro nucleare e di guerra mondiale. Inoltre ha avviato un processo che permette di pensare a un percorso negoziale. La pace è questione complessa ed è frutto di un processo, non lineare, per molti versi arduo, ma necessario. La ricerca della pace avviene nel cuore della guerra, su un terreno ambiguo per sua natura. Le trattative nascono “deboli”. Le ragioni della guerra e l’azione bellica sembrano più forti. Lo vediamo in questi giorni con la prosecuzione e l’intensificazione dei bombardamenti sulle città e dei combattimenti al fronte. Per fare la pace bisogna trattare con chi fa la guerra. Se dovessero prevalere preclusioni di carattere ideologico verso una delle parti, per quanto possano essere fondate, l’unica alternativa sarebbe arrivare alla resa dell’avversario, in altre parole alla vittoria. Ricordava Hannah Arendt nel 1969, che nell’epoca della guerra termonucleare, «il famoso evento casuale» – cioè lo scoppio accidentale di una guerra atomica – è più probabile che si verifichi dove prevale il vecchio adagio «non c’è nessuna alternativa alla vittoria». La pace ha bisogno di tempo e di perseveranza. Ci rendiamo conto che la risoluzione della guerra in Ucraina non sarà questione di formule (di pace) magiche, né che si possa mettere fine alla guerra in quarantotto ore. Il negoziato è dialogo e il dialogo è l’arma decisiva nella costruzione della pace. Questo è il momento della pace attraverso il dialogo. Si parte da posizioni distanti, spesso incompatibili, a volte inaccettabili: ma i processi negoziali servono quando le guerre sono in corso e le posizioni contrapposte. E l’Europa? Sebbene marginalizzata, non può considerarsi estranea a come si risolverà la guerra sul continente, in primo luogo perché in questa guerra è coinvolta. Non è il riarmo la via per tornare in gioco. «Una forte militarizzazione non difende la pace; porta alla guerra», hanno scritto 2.500 scienziati in un loro recente appello. Serve una scelta forte per la pace, attingendo alle risorse che i paesi europei hanno trascurato in questi ultimi tre anni: quelle del dialogo, della diplomazia, della politica. Non il velleitarismo della ricerca di una risposta militare che faccia la differenza, ma l’immaginazione creativa di proposte politiche che rilancino una visione di pace e di sicurezza per l’Europa. La prospettiva rassicurante del futuro, per noi europei compresi gli ucraini, non può essere quella di una condizione di permanente preparazione alla guerra contro un nemico considerato inesorabile. Occorre iniziare a pensare una nuova architettura dello spazio europeo che accetti la sfida, davvero non semplice, di ritrovare una via di dialogo e di coesistenza nella sicurezza con la Russia. Lo scambio di prigionieri e il rilascio di militari ucraini gravemente feriti, annunciati dopo la conversazione telefonica tra Trump e Putin, ricordano che la guerra è vissuto drammatico di persone, dei combattenti, ma anche di donne e uomini, anziani e bambini, di inermi, vittime della violenza bellica. L’attenzione alle questioni umanitarie non può essere trascurata. L’impegno umanitario contribuisce alla pace. L’ha iniziata a costruire in questi tre anni, quando non era aperto nessun altro canale, se non quello della diplomazia umanitaria, come ha dimostrato la missione del card. Zuppi. L’orizzonte umanitario deve restare un riferimento anche in questo processo travagliato. E ci ricorda che la pace non è per la nostra tranquillità, ma è in primo luogo per gli ucraini. Della sofferenza degli ucraini ha parlato dal palco di piazza del Popolo a Roma la voce di una donna ucraina. Conviene ascoltarla: «La gente è stanca. C’è bisogno di pace. La nostra sofferenza chiede oggi una pace giusta per l’Ucraina. Oggi dico a tutti voi che noi attendiamo questa pace. Noi vogliamo la pace». Meglio una voce di questo tipo che conosce le sofferenze di un conflitto quasi infinito che un’altra di casa nostra, infarcita di tanta retorica e poca consapevolezza.
Carlo Cammoranesi